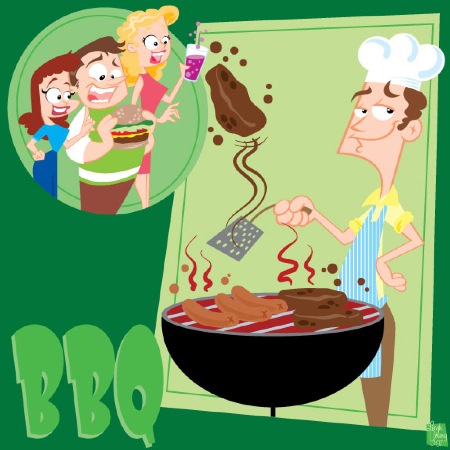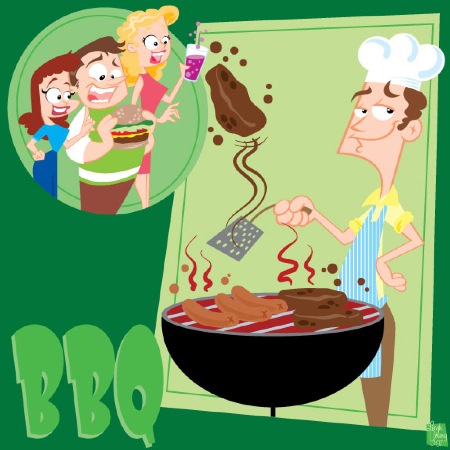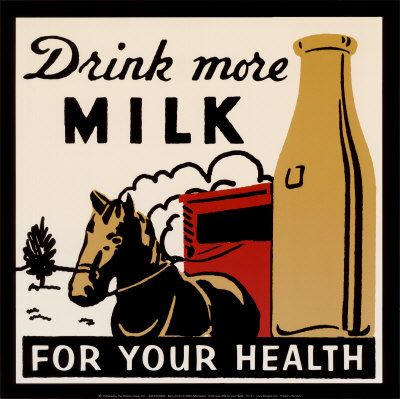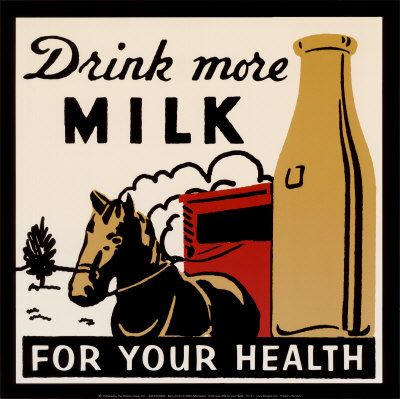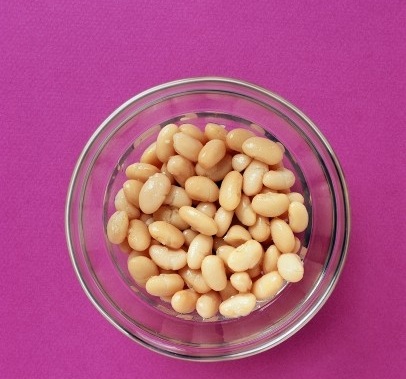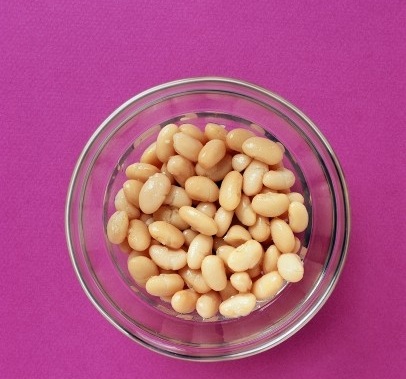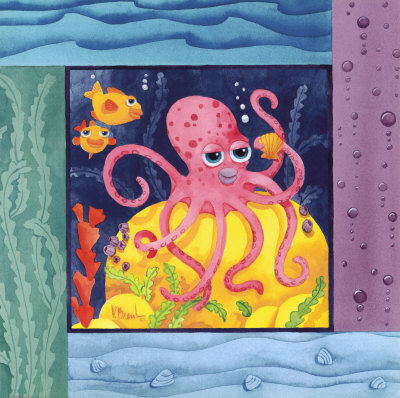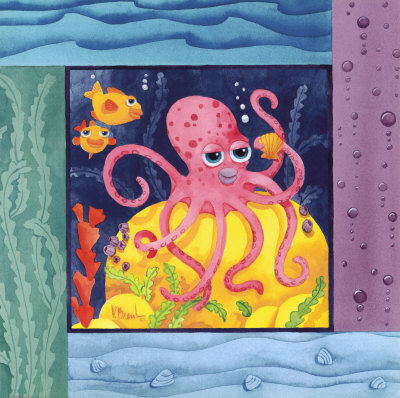Il difetto principale delle diete secondo me è che sono noiose ed influiscono così sul nostro umore. “Cosa hai mangiato ieri sera?” “Mmm…un’insalatina verde…” Vuoi mettere con “mi sono mangiato un bel piatto di spaghetti alla carbonara!” Tutta un’altra cosa! Il punto sta nel far diventare appetitosa anche una misera insalata. Ma come? Con un po’ di colore, un po’ di fantasia e l’abbinamento giusto!
Cominciamo dalla materia prima: l’insalata. Intanto nessuno ha detto che esiste solo la lattuga. Parola d’ordine “variare“:dalla lattuga romana alla valeriana, dal radicchio all’indivia, dalla cicoria alla rucola, ognuna ha un suo sapore ed una sua consistenza.
Seconda parola d’ordine: “abbinamenti“. Ad un’insalata potete aggiugere anche alimenti più sostanziosi come la carne (una bella insalata di pollo?), il pesce, il formaggio, le uova e, perchè no, anche la frutta.